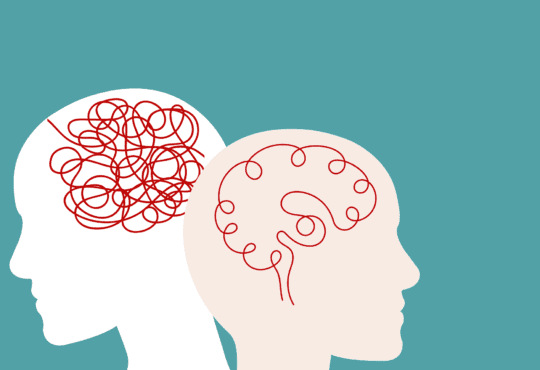Quando tocco il vuoto – la paura nell’istante in cui non sono
Se devo morire non lo farò in pigiama.
Fu questa l’unica frase che riuscì a balenarmi nella mente mentre il cuore palpitava, la schiena s’inarcava e il fiato si spegneva.
Così d’un tratto mi alzai dal letto, aprii l’armadio e indossai un paio di jeans e una felpa.
M’infilai nuovamente sotto alle coperte. E attesi.
E nell’attesa cercai di pensare a qualcosa di bello. Un viaggio, un bacio, un sogno.
Tutto ciò che la mente produsse, però, fu il ricordo di un peluche che avevo da bambino.
Che strano. Una vita intera a chiedermi quale sarebbe stato il mio ultimo pensiero prima di morire per poi scoprire che la mia esistenza si sarebbe interrotta, di lì a poco, soffermandosi sul ricordo di Musti (questo il nome dell’orsacchiotto) che mi guardava dal divano con sguardo dolce e inebetito.
Cosa c’è sotto alla tua pelle di stoffa? Un cuore o altra stoffa? Cosa succederebbe se ti strappassi un orecchio, proveresti dolore? Sarebbe uguale al mio?
Quella notte pensai che morire a letto sarebbe stato strano.
Non morire, quella notte, lo fu ancora di più.
Ciò che accadde quella notte fu un semplice, fulmineo, inaspettato attacco di panico.
Ciò che accade da quella notte sono semplici, fulminei, inaspettati attacchi di panico, che si configurano nel Disturbo da panico.
Il letto rappresenta il mio acerrimo nemico. Faccio di tutto per posticipare il più a lungo il momento in cui devo, per forza di cose, andare a dormire.
Le ho provate tutte.
All’inizio ho provato a non indossare il pigiama. Se mi accade qualcosa, mi troveranno in condizioni dignitose, magari indosso una camicia.
Poi ho cercato di addormentarmi su una sedia. Ho male alla schiena, ma sono vigile. Se il respiro si ferma, avrò la forza per gridare aiuto?
Poi è toccato alla lettura. Gli occhi bruciano, le palpebre tremano. Ma il cuore ancora palpita, e palpita, e esplode.
E all’autoerotismo. La stanchezza si arrende a un orgasmo forzato, che stilla piacere e paura.
Sono stati tutti tentativi vani.
Il letto è una tomba scoperta. Le lenzuola fasciature per nascondere i tagli e le ustioni. Il cuscino un ultimo abbraccio, prima dell’addio.
La situazione è precipitata quando ho capito che gli attacchi di panico non si manifestavano solo nel momento in cui mi mettevo a letto.
Ero al ristorante.
La mia compagna sorride mentre si porta alle labbra un calice di vino.
Ricambio lo sguardo, sono sereno.
Lei mi fa una domanda.
Io non capisco.
Ed è il vuoto.
Il collo s’irrigidisce, le gambe tremano, l’occhio osserva spaventato e la vista si offusca.
Non sono più lì.
Mi guardo intorno. Il viso della mia compagna non mi è più familiare. Provo a parlare, a gridare aiuto!, ma la voce geme, si spegne in un parossismo di terrore.
Sto morendo qui, adesso.
Sto morendo senza capire cosa succede.
Sto morendo e non penso ai viaggi, ai baci e ai sogni.
Quel giorno al ristorante non sono morto. Si è però instaurata in me la sensazione di aver semplicemente posticipato un momento che, da lì a poco, mi avrebbe strappato alla vita.
La privazione del sonno è stata spesso utilizzata come forma di tortura. Cosa fare, però, quando si è al contempo vittima e carnefice? Quando, ogni notte, si ha la sensazione che potrebbe essere l’ultima?
Una sera ho pregato.
Il terrore m’impediva di respirare, con le mani cercavo di portarmi aria alla bocca.
Dio, se esisti, non sono ancora pronto per morire.
Dio, se esisti, non sono ancora pronto per vivere così.
Avrei forse dovuto anticipare il mio destino? Cedere alla tentazione di indagare la mente, la mia, assecondare la paura di dormire, per dormire per sempre?
Il suicidio di uno dei miei migliori amici mi aveva messo di fronte a una rivelazione: la morte può essere una scelta.
Così, una notte, ho scritto la mia lettera d’addio.
“Cari tutti,
sarò sincero: ho immaginato così tanto le mie mani tremanti che scrivono queste parole che, farlo adesso, mi sembra la naturale prosecuzione di un sogno ad occhi aperti.
Ho avuto sogni deboli e occhi stanchi. Ho guardato alla felicità con sospetto, come un premio sul quale non avevo alcun diritto. Dovrei cercare delle motivazioni, vero? Dirmi che le vie per la felicità sono infinite.
Potrebbe essere vero. Ma sento di non avere gambe abbastanza forti per solcare strade che non siano quelle del dolore pigro, passivo, asfissiante.
Eppure non guardo alla tristezza come a una malattia. Non è che un sintomo blando, una febbre che si esaspera perché non ce ne si prende cura.
La malattia sono io.”.
Che senso avrebbe avuto perorare una vita in cui mi sentivo costantemente pieno e vuoto, affamato e sazio? Una vita in cui gli occhi stanchi e arrossati non vedevano più lucidamente le sfumature di colori? Una vita in cui mi trascinavo con il terrore e la nausea?
Ma, soprattutto, che senso avrebbe avuto morire?
A volte è assurdo pensare che ci si perde nelle prime luci che abbagliano senza notare le sfumature, i particolari.
Così ho chiesto aiuto. E l’ho ricevuto.
Sono seguito da due professionisti che mi hanno insegnato a gestire le crisi di panico, gli inganni della mente e i pensieri ossessivi. La ruminazione mentale è lentamente scemata, fino a diventare gestibile.
Gli psicofarmaci, poi, hanno fatto il resto.
Quindici gocce baciano la lingua, vi si nascondono sotto e sfiorano il palato, rendendolo amaro.
Una goccia per sentire tutto, e meglio.
Un’altra per tacere.
Una goccia per sentire poco, e tutto.
Una ancora per non sentire niente.
Gli psicofarmaci non sono pozioni magiche. La sensazione di avvertire i pensieri negativi ovattati va gestita, implementata al proprio comportamento. È per questo che la psicoterapia rappresenta l’alleato d’eccellenza per imparare le tecniche di gestione d’ansia e panico.
E, soprattutto, bisogna avere il coraggio di tendere la mano aspettando che qualcuno la colga, e l’accarezzi. Anche se, come me, il coraggio non lo si ha.
Non so se le persone possano salvarsi da sole, so solo che la mia mente è diventata un’alleata in grado di farmi comprendere al meglio i miei limiti e i miei pregi.
Ogni tanto le crisi di panico notturne continuano a farmi visita.
Non sfilo il pigiama, non indosso camicie.
Non mi addormento su una sedia.
Il cuore palpita, palpita e esplode, perché mi dice ci sono, continua a sentirmi.
Porto una mano al petto, premo forte e mi dico che va tutto bene, che andrà tutto bene.
Che la mano che sento sul petto è la mia, che ci sono, che esisto ancora.
Che il letto può essere una tomba, certo, ma anche un prato.
La morte può essere una scelta, deve poterlo essere.
La vita, anche.
Perché non voglio più dormire con la luce accesa.
Se devo vivere non lo farò in pigiama.
Giuseppe De Filippis