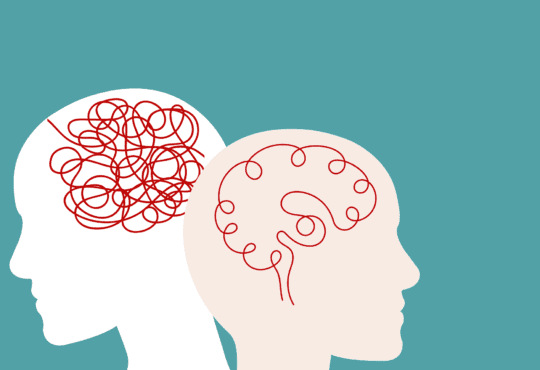Quando da bambina vedevo le mamme dei miei compagni rincorrerli per il cortile di casa brandendo un cucchiaio colmo di pasta che cercavano di ficcare nelle bocche serrate dei loro figli, pensavo di avere a che fare con un mucchio di deficienti.
Per me non esisteva una gioia più grande del cibo.
Mi avevano insegnato che mangiare era prima di tutto un modo per stare insieme: le occasioni di riunioni familiari erano sempre pranzi, cene, feste. E il cibo che si preparava e si consumava in quelle occasioni era così abbondante che avanzava sempre, si regalava sempre, si invitava sempre altra gente a condividerlo con noi. Mangiare era un atto di condivisione del proprio bene e della propria fortuna. Lo sapevano bene i miei nonni che, cresciuti in tempo di guerra, avevano sofferto la fame e, dopo aver mangiato bucce di patate raccolte dalla spazzatura, non ne volevano più sentire di patire ancora per lo stomaco vuoto. Ogni giorno in cui ci si sedeva a tavola, era un giorno in cui non si sarebbe sofferta la fame. Dalla fame all’eccesso ci sono arrivati senza neanche accorgersene.
E così sono nata io, cresciuta con l’idea che la giornata si scandisse in base ai pasti.
Si vedeva già da quando ero bambina che non sarei mai stata esile: la mia corporatura rivelava un destino segnato dalla robustezza. Oltre al fatto di avere una discreta fame. Mi dilettavo in simpatici giochi di astuzia consumando pasti doppi o tripli in base a dove mi trovassi: se a casa della nonna pranzavano alle 12 e a casa mia alle 13, mi destreggiavo onorando entrambe le tavole e consumando doppio pasto. Sia mai che qualcuno si potesse offendere.
Ma questa mia destrezza aveva risultati visibili. Al punto che fui messa a dieta per la prima volta a 8 anni. Me la ricordo quella privazione che è cominciata quando non ero ancora entrata in pubertà eppure avevo già delle belle tettine grassose. Mi ricordo di aver conosciuto la parola “sacrificio” prima ancora di conoscere l’espressione “licenza elementare”.
E quando mi iscrivevano a ginnastica artistica, nuoto, danza o qualunque attività sportiva in cui mi piazzavano in mezzo a bimbette della mia età che pesavano la metà di me, che potevano indossare i body e i costumi senza vedere la ciccia fuoriuscire da ogni scollatura, mi rendevo conto di essere sempre quella diversa. Nelle esibizioni di danza – pur essendo una discreta ballerina- mi ero guadagnata il posto in ultima fila perché “sei più alta”. Ma in realtà era solo perché tutti potevano vedermi lo stesso se stavo dietro una fila di esili creature. Mentre se avessero piazzato me davanti, quelle piccoline se le sarebbe mangiate il mio culone al primo pas de bourrée.
Mi ero un po’ rassegnata a quel ruolo: alla fine era pur sempre una parte che mi era stata concessa, meglio la bimba grassa che la bimba invisibile. Eppure, nonostante la mia mole, non si contano le volte in cui mi sono sentita trasparente. All’epoca pensavo che fosse l’essere diverso ad escluderti automaticamente da ogni dinamica sociale. Fu così che, per sopperire a quelle esclusioni, puntai ad altri modi per farmi accettare dai miei coetanei.
Sono sempre stata una bimba ingenua. E la mia ingenuità è stata più volte abusata.
Quello.
Quello è stato il momento in cui è cambiato il mio rapporto con il cibo e con il mio corpo.
Adesso, a distanza di anni e un po’ di terapia, sono stata capace di mettere un punto nella mia linea temporale da cui ho tracciato la parabola discendente.
Fino a quel momento mangiare aveva un’unica motivazione: la golosità. Dopo divenne una scappatoia, una fuga, un rifugio…e ad un certo punto un modo per costruirmi un’armatura. Avvolta da strati di grasso mi sentivo protetta. Se avessi fatto schifo abbastanza da non attirare gli sguardi su di me, mi sarei salvata.
Spoiler per chi stesse pensando di imitare questa strategia: non funziona.
Le vittime di abusi tendono sempre a colpevolizzarsi e, se ci fate caso- come la mia terapista mi ha fatto notare spesso- anche in queste parole io ho trovato il modo di prendermi la colpa: ero io che ero troppo ingenua, ero io che volevo farmi accettare, ero io che non dicevo no, ero io che…
Ero io che ero solo una bambina e non avevo colpe. Ma non lo sapevo e allora mangiavo e mangiavo e mangiavo: per mandare giù la colpa la masticavo nervosamente e la ingoiavo per riempire il vuoto che si faceva sempre più grande ad ogni boccone.
La colpa non è un cibo che sazia. È un alimento che scava ulcere dolorose.
Intanto, da fuori continuava a sembrare che la mia fame fosse ancora golosità. Ma dentro sapevo che stavo mangiando me stessa, stavo divorando la persona che ero diventata, stavo prendendo il controllo di ciò che entrava nel mio corpo per rispondere alle volte in cui il controllo non lo avevo avuto.
È stato difficile ammettere prima di tutto a me stessa di avere un disturbo comportamentale dell’alimentazione. Innanzitutto perché se parli con un po’ di gente in giro capisci che il disturbo viene associato all’anoressico o al bulimico, raramente all’obeso. L’obeso è un vizioso, uno che gode dei piaceri della vita e che non si fa problemi a cedere a qualunque tentazione. L’obeso è un edonista che si merita il corpo che ha perché non se ne sa prendere cura. Mah. Magari in qualche caso può essere vero, non lo escludo. Ma nella realtà dietro questo impeto famelico c’è sempre una motivazione più profonda.
Non tutti sanno che i disturbi comportamentali dell’alimentazione sono disturbi psichiatrici, il cui approccio terapeutico è molto più complesso di un banale “mangia di meno e muoviti di più”. Sono convinta che non se ne esca mai del tutto. È una parte di noi che non ci lascia mai, nemmeno quando sembriamo al meglio della nostra forma. E torna, come un tarlo, a rosicchiare i bordi della nostra autostima non appena qualche aspetto della nostra vita inizia a vacillare.
Ah poi, quando si è fortunati come me, al disturbo psichico si aggiunge quello fisico: non a tutti è fatto dono, contemporaneamente, anche di una sindrome metabolica e di una disfunzione tiroidea. Il ché sembra una cosa brutta ma in realtà ti permette di mascherare il disagio della mente con una patologia riconosciuta: è più facile dire sono grasso perché non mi funzionano delle ghiandole, anziché dire sono grasso perché la mia mente mi dice di mangiare quando in realtà ho bisogno di altro.
Ma disfunzioni a parte, che giocano il loro ruolo nel tentativo di riprendersi la propria sanità mentale, ho deciso, dopo anni di silenzio conservativo, di condividere questo mio segreto oggi perché buona parte del peso che mi porto addosso non si può quantificare in kg o cm. La zavorra più pesante di cui non si riesce a liberarsi con le diete o con l’attività fisica è il disturbo comportamentale.
E per anni, per tanti anni, mi sono sentita proporre la dieta X, lo sport Y, l’attività Z, vedendo i risultati che avevano ottenuto quelli che intorno a me avevano sperimentato i metodi più innovativi per mettersi in forma.
Quante ne ho provate.
Quante volte ho provato a sistemare la carrozzeria di una macchina che invece aveva fottuto il motore.