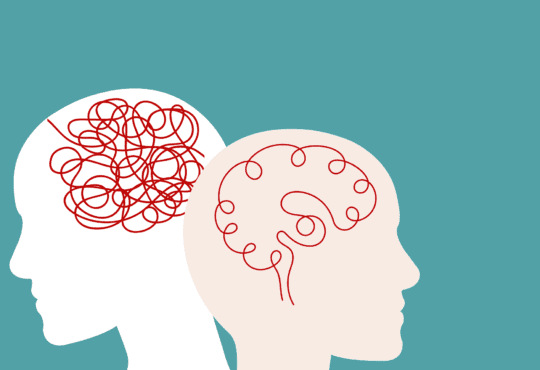Non ricordo il rumore dei tacchi di mia madre che battevano sul freddo marmo delle scale.
Non ricordo il suo affanno né i singhiozzi che si alternavano ai passi.
Non ricordo la sua mano dietro la mia nuca per attutire il rinculo della corsa lungo le rampe di quel palazzo, che, avrà immaginato, essere infinito.
Non ricordo le parole con cui mi ha abbracciato né quante volte si sia chinata per baciarmi la testa, mentre riprendeva fiato.
Non ricordo le mani, le mie e le sue, strette lungo la salita.
E non ricordo il sollievo, o la paura, quando il vento ci ha sferzato il viso non appena ha aperto la porta della terrazza del palazzo.
Non ricordo, né potrei. Avevo due anni, una bocca silenziosa e una madre disperata.
Non ricordo, ma vorrei.
Avere memoria di quella volta in cui mia madre cercò di porre fine al dolore, il mio e il suo, tentando di gettarsi dal tredicesimo piano di un edificio.
A questo punto è necessario parlare degli avvenimenti che portarono a quella notte.
Sono nato in un corpo di vetro. Ogni sospiro poteva trasformarsi in una crisi respiratoria. E, come tutti gli oggetti fragili, sono stato trattato da fragile. Ero un pacco di cui ci si prendeva cura più dell’involucro, che del contenuto. Perché non dovevo, né avrei mai dovuto, fare qualcosa che potesse farmi mancare il fiato.
Il fiato, a dire il vero, da bambino l’ho perso tante volte.
Ricordo la prima volta in cui imparai a fischiare. Era durante la pausa merenda dell’asilo. All’uscita di scuola, con la mano alzata, mia madre attendeva che le corressi incontro. Non appena fui abbastanza vicino da potermi farmi sentire, fffiu!, ecco il primo fischio di tuo figlio, mamma. È un regalo per te. Ed ecco che il sorriso più caloroso del mondo si faceva largo sul suo viso. Un sorriso che poi divenne smorfia, e panico. Avevo iniziato a tossire e non sarei stato in grado di smettere fino alla notte successiva, sul letto di un ospedale.
E ricordo ancora una delle mie prime corse all’aria aperta.
Eravamo alle Canarie. Mamma aveva insistito così tanto per quel viaggio.
Si era convinta che farmi salire a diecimila metri di altezza avrebbe potuto portare benefici per le mie crisi respiratorie.
Se ci penso adesso trattengo a fatica un sorriso, e con maggior difficoltà le lacrime. D’altronde era lecito che una madre fosse accecata così tanto dal benessere del figlio da provarle tutte.
I miei genitori scelsero una meta che prevedesse una rotta lunga. Tenerife. Quattro voli, due all’andata e due al ritorno.
E così ci ritrovammo imbarcati in un viaggio che non avremmo potuto permetterci.
Mamma sembrava la persona più felice del mondo.
Ma ritorniamo alla corsa.
Come un cane che si accorge che il padrone ha lasciato distrattamente il guinzaglio, con uno sguardo osservo gli occhi di mia madre, che stranamente non sono rivolti su di me.
E corro. Corro sul bordo della piscina, tra gli spruzzi dei bambini, corro lungo il porticato del bar tra i tavoli degli astanti. E corro nel giardino immenso che porta alla hall dell’albergo. Di girarmi indietro non ho alcuna intenzione.
Eppure qualcosa inizia a non funzionare più, a funzionare meno. Sento il cuore in gola, lì dove non dovrebbe essere. E le gambe non reggono il respiro, le ginocchia si flettono e le mani graffiano il terreno. Non ho più fiato.
I miei genitori corrono verso di me. Sono spaventato, ma quando arriva mamma le dico Hai visto, sono stato bravo. Mamma, sono stato bravo perché mi resta ancora un po’ di fiato per dirti quanto mi sono sentito bene, e poi male, e poi il buio.
L’ultimo anno di asilo l’ho dovuto saltare. I ricoveri erano diventati sempre più frequenti, le diagnosi sempre più nefaste. E così ho iniziato a frequentare l’asilo messo a disposizione dall’ospedale.
Sarò sincero, non ho ricordi brutti legati a quel periodo. Giocavo, disegnavo, abbracciavo, mi esaminavano, ogni tanto dovevo svegliarmi all’alba, ma il motivo ora mi sfugge, né mi sarà mai chiaro. Mamma è sempre stata brava a normalizzare situazioni diverse. E se chiedevo quanto ancora a lungo sarei dovuto rimanere in ospedale, ecco che di sera venivano a trovarmi i miei parenti, che puntualmente mi riempivano di giochi – ho dolce memoria dei Power Rangers – e di attenzioni.
Ho solo un brutto ricordo dell’ospedale. Fu lì che per la prima (e ultima) volta vidi mia madre piangere. Al suo pianto si unì ben presto il mio. Non perché capissi cosa stesse succedendo a me, ma perché non ero in grado di capire cosa stesse succedendo a lei.
La malattia, così come la morte, erano concetti astratti e lontani per me. Qualcosa che sarebbe potuta accadere, ma non nel mio mondo. E nemmeno in quello dei miei cartoni animati, dove i Pokémon non morivano, erano semplicemente esausti.
E tu, mamma, quella notte sarai stata davvero esausta.
Il vento ci avrà sicuramente schiaffeggiato il viso, su quel terrazzo. E l’edificio in cemento armato era già pronto a custodire il nostro segreto, il rimedio a cui avevi pensato e che avresti condiviso solo con me.
E io provo a immaginarti mentre, tenendomi in braccio con delicatezza avrai pensato ancora una volta solo e soltanto al mio bene.
E se mi sforzo un altro po’ posso addirittura ricostruire ciò che mi avrai detto, in quella che credevi dovesse essere l’ultima occasione.
Perdere il fiato insieme, questa volta, per non farmelo perdere da solo.
Eppure basta così poco per cambiare il corso degli eventi. Mentre mi tieni in braccio ti osservo, ti stringo l’indice e ti sorrido. Un sorriso di gengive rosse nascoste da labbra che non sanno ancora dirti nulla, mamma, ma che ti diranno poi. E quel poi lo costruisci tu, quando ormai l’edificio ti appare minuscolo, e il vento una carezza, e il mondo il posto in cui meritiamo di stare entrambi.
Quest’ultima parte è l’unico pezzo di storia che conosco con certezza, perché me l’hai raccontato tu, pochi anni fa. E qualche mese fa mi hai detto che ho capito male, che non ricordi, che forse hai sognato tutto.
Ora sto bene. Le crisi respiratorie sono un ricordo di un passato in cui non sono più, né nel quale potrei immergermi ancora, perché ho ricordi ovattati. Anche a me, a volte, sembra un lungo sonno.
Ora sto bene. Anche se i segni sul mio corpo fanno riaffiorare ciò che la memoria cerca di nascondere. E lo so che te ne accorgi, mamma, quando preferisco indossare la maglia nera anziché quella bordeaux per celare allo sguardo altrui pezzi di carne lì dove dovrebbe esserci il torace.
Ogni tanto mi guardi ancora come se potessi spezzarmi da un momento all’altro, e a volte accade proprio sotto al tuo sguardo.
E vorrei dirti, mamma, che non ho più un corpo di vetro ma di carta, che assorbe le cose belle e quelle brutte, che alla fine sono la stessa cosa.
Pezzi di vita che m’inzuppano rendendomi eccessivamente felice, o eccessivamente triste.
Pezzi che, ancora oggi, qualche volta, hai la forza di asciugare.
Giuseppe De Filippis