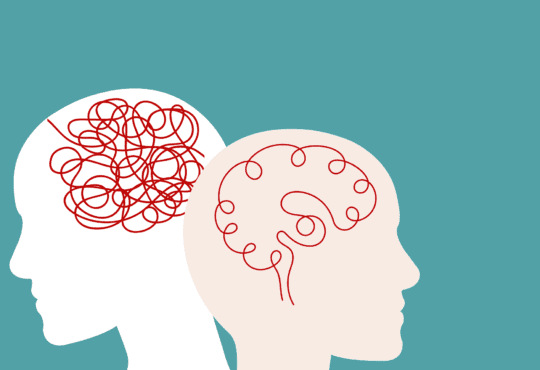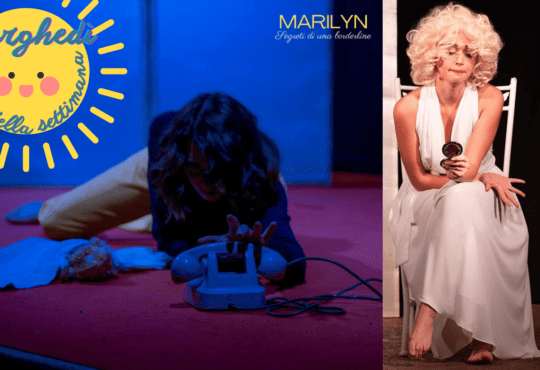“La tua vita è la tua vita. Non lasciare che le batoste la sbattano nella cantina dell’arrendevolezza. Stai in guardia. Ci sono delle uscite. Da qualche parte c’è luce. Forse non sarà una gran luce ma la vince sulle tenebre. Stai in guardia. Gli dei ti offriranno delle occasioni. Riconoscile, afferrale. Non puoi sconfiggere la morte ma puoi sconfiggere la morte in vita, qualche volta. E più impari a farlo di frequente, più luce ci sarà”. (…)
(Il cuore che ride, C.Bukowski)
Settembre 2017. Chi scrive è nel baratro, ai piedi dell’abisso. La sua vita oscilla da ormai due anni tra crisi di nervi e un rassegnato encefalogramma piatto di assestamento. La sensazione generale è che gli anni migliori si stiano dissolvendo come un pugno di sabbia inghiottito dal mare, a poco a poco. Si respira un’inquietante aria di disarmo, di sconforto, di ferite mai rimarginate e frustrazioni bollenti. E i giorni passano, passano, passano. In un contesto desolato, paradossalmente è l’università a fornire gli unici sprazzi di evasione: anche la quotidianità della vita sociale, infatti, è ormai in parte condizionata da quel malessere “anestetizzato” ma ben vivo. Il flusso dei giorni si trascina così, stancamente, fino a gennaio 2018.
Al giorno in cui mio padre, entrando quasi distrattamente in camera, mi comunica che si è aperto il bando per entrare nella compagnia teatrale pubblica della città in cui vivo.
Ci provava da anni, a cadenza mensile, anche in assenza di esplicite opportunità.
“Perché non fai teatro?”
Non gli avevo mai dato ascolto, e le mie reazioni indifferenti lo avevano demoralizzato a tal punto che dal suo tono dimesso e rassegnato ebbi la sensazione che sarebbe stata l’ultima volta che me l’avrebbe detto. In passato avevo già partecipato a spettacoli teatrali con la scuola, ma lo stato di crisi in cui ero e l’apatia cronica che aveva scaturito avevano soffocato anche il fiorire di passioni ben più radicate nel mio essere, come la scrittura. Non c’era più spazio per alcun bagliore di novità nel pallido susseguirsi dei miei giorni, figurarsi per il teatro.
Naturalmente, non gli diedi retta neppure allora. C’era un mese di tempo per rispondere al bando, il che mi fornì un assist per temporeggiare. Ma in realtà sapevo benissimo che, come sempre, non avrei mai risposto.
Tuttora non riesco a identificare cosa fu esattamente a spingermi quel 15 febbraio 2018 – a due giorni dalla scadenza del bando – a inviare la mia candidatura. In realtà, avevo anche dimenticato del bando: a riportarmelo alla mente, come un flash, fu uno sguardo distratto all’abbandonato banner verde della sezione “Aggiornamenti” della casella email.
Forse si trattò semplicemente di un’azione dalla genesi e dalla motivazione totalmente casuali: di quelle che si compiono quasi come un’inerzia ribelle, giusto per vedere l’effetto che fa, oppure per l’ebbrezza di seguire, per una volta, una strada consigliata – pur pensando già oltre, pensando che sarebbe stato soltanto un modo in più per far trascorrere diversamente il tempo.
Pensando che di certo, come del resto qualsiasi altra cosa ormai, non avrebbe cambiato nulla, né mi avrebbe restituito qualcosa, o qualcuno.
Quell’anno era in programma un adattamento di Guida Galattica per Autostoppisti, celebre romanzo di Douglas Adams.
Dopo i primi incontri interlocutori, ma a dire il vero piuttosto interessanti – i quali mi trasmisero un’ormai quasi dimenticata percezione di energia vitale – giunse il giorno della distribuzione delle parti dello spettacolo. Durante le prime prove, caratterizzate da una serie di esercizi volti ad affinare il ritmo di movimenti, espressività e battute e la capacità di sviluppare determinate situazioni a tema, mi ero calato con curiosità mista a una strana voglia di “stupire” nelle varie attività. Ma certamente, anche a causa di un carattere non esattamente espansivo, non credevo di essermi fatto notare più di tanto dall’autore dello spettacolo, e neanche dagli altri ragazzi della compagnia, con cui comunque avevo stretto un buon rapporto.
Quel giorno eravamo seduti uno di fianco all’altro sul palco quando l’autore, seduto di fronte a noi, prese una risma di fogli dal banco e cominciò a leggere i ruoli a partire dal protagonista.
“Arthur Dent…”
“… sarà Mattia”.
Protagonista.
Lo spettacolo sarebbe stato di lì a tre mesi, in un teatro non enorme ma che sarebbe comunque stato stracolmo. Non c’era pagina del copione che non mi coinvolgesse, e non mi esprimevo davanti a un pubblico da anni, laurea esclusa.
Eppure, nell’apparente immutabilità del ritmo delle prove, qualcosa stava davvero cambiando. Dal momento dell’assegnazione della parte iniziai, per la prima volta dopo tanto tempo, a riprovare curiosità verso me stesso, a riesplorarmi attraverso Arthur. A cercare di dargli qualcosa di mio (nonostante in parte mi somigliasse, parziale risposta alla domanda “cos’avrà visto l’autore in me per scegliermi?”), e allo stesso tempo a lasciare che fosse la sua essenza curiosa di personaggio ad indicarmi il cammino, la ricerca del mio equilibrio, di tutto ciò che potevo e avrei potuto mettere su una tela che finalmente poteva contare su una tavolozza con un po’ di colore.
Silenziosamente, e lasciandomene rendere conto a poco a poco, il teatro mi stava omaggiando del più utile dei paradossi: svincolandomi da me stesso mi stava ridando una dimensione, mostrandomi tutti i modi possibili in cui potevo, semplicemente, essere. E in cui poteva prendere forma tutto ciò che era intorno a me, Arthur compreso. In fondo, a teatro ero davvero libero: libero di modellare la mia voce, i miei movimenti, perfino le mie assenze.
Cominciai ad essere più Arthur, a divertirmi a trovare il modo di adattarmi ad ogni situazione possibile, anche a casa, all’università, con gli amici, con me stesso. Avevo deviato il percorso della mia vita, riprendendone il filo, attraverso la sua. E senza sapere il come, né il perché, stava funzionando. Non so se fosse la strada migliore, ma dopo tanto tempo, era di nuovo la mia, perché l’avevo scelta io, perché io le stavo dando forma.
Perché pian piano, il mio stato d’animo, ciò che mi riguardava, stava tornando, attraverso Arthur, a dipendere da me.
E tanto bastava.
Lo spettacolo fu un successo: il teatro era pieno in ogni ordine di posto e tutti rendemmo al meglio. In quei tre mesi la compagnia era diventata un blocco unico e determinato. Difficilmente dimenticherò (e dimenticheremo, credo) i brividi dietro le quinte, prima di entrare in scena, durante le presentazioni di rito. Dal sipario si intravedevano le sagome del pubblico che man mano riempiva il teatro, mentre in noi dominava la sensazione di non ricordarsi più nulla. Fortunatamente, rimase una sensazione. Eravamo pronti. E Arthur, senza far rumore, si era già impossessato di me, e per quelle due ore ci fu soltanto lui su quel palco, anima spuria in corpo altrui. La mia spalla, che interpretò il ruolo dell’insolente amico alieno, fu eccezionale, come alle prove del resto. Avevamo sviluppato un’intesa ormai telepatica.
Quattro giorni dopo lo spettacolo partii per la Germania. Non ero mai salito su un aereo prima in vita mia, inizialmente per timore. E in realtà negli ultimi anni non volevo neppure salirci, perché non volevo più andare da nessuna parte, non ne vedevo più il motivo. La luce si era spenta da tempo, e l’assuefazione all’opacità aveva tolto anche la voglia di riaccenderla. Quel viaggio post-teatro verso Francoforte fu il primo di altri 15, in un solo anno. Ma questa è un’altra storia, e non è neanche la più importante.
Mi piacque pensare, piuttosto, che si trattasse dell’ultimo regalo di Arthur: un viaggio non solo fisico. Un viaggio di ritorno, definitivo, verso la vita.
“I know it seems strange, but things, they change…”
(The Courteneers, Not Nineteen Forever, da St. Jude, Polydor Records, 2008)